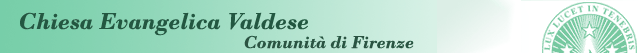 |
Torna
alla Home page |
C’è una sola rivelazione di Dio o ce ne sono tante?Tratto dalla rubrica "Dialoghi con Paolo Ricca" del settimanale Riforma del 2 Novembre 2007
In un suo libro intitolato Il Vangelo secondo la Scienza (Einaudi 1999), Piergiorgio Odifreddi si sforza di dimostrare che qualsiasi forma di religione è in contrasto con la ragione e quindi con la scienza. Egli analizza i vizi di logica addebitabili secondo lui alle varie religioni. Tra queste è annoverato il protestantesimo che, sorprendentemente, viene considerato dall’autore una sorte di «religione» diversa dal cattolicesimo anziché un modo diverso di declinare il cristianesimo. Non ho trovato particolarmente interessante questo libro nel suo complesso, tuttavia mi ha fatto riflettere proprio il paragrafo che cita il protestantesimo, catalogandolo, insieme all’ebraismo, come «religione ermeneutica», in quanto basata sulla lettura e l’interpretazione diretta della Bibbia. Perché mi ha fatto riflettere? Perché mi sembra che un approccio alla teologia che privilegi in modo quasi esclusivo l’interpretazione del testo biblico possa dar luogo a cortocircuiti come questo: «Credo in Dio perché lo dice la Bibbia e credo alla Bibbia perché lo dice Dio (o perché è lì che Dio parla»). Ora è vero che la teologia della Riforma ritiene che Dio possa essere conosciuto solo accettando la parola della predicazione basata sulla testimonianza della Scrittura (Sola Scriptura), ma è altrettanto vero che questo principio fondante non dev’essere disgiunto dagli altri tre: solus Christus – sola gratia – sola fide. Mentre questi tre ultimi principi sembrano oggi condivisi, pur tra molte esitazioni, resistenze e contraddizioni, dall’ecumene cristiana, il sola Scriptura resta il segno distintivo del protestantesimo. Mi chiedo allora: ma Dio si rivela solo nella Bibbia? In che rapporto sta il canone biblico, che consideriamo definitivamente chiuso, e la Parola che crediamo incarnata nel Cristo vivente? In altre parole: la rivelazione è chiusa oppure aperta?
Andrea Mela – Coazze Qui le domande sono almeno tre. La prima (implicita) è: ha ragione Piergiorgio Odifreddi a considerare il protestantesimo una «religione ermeneutica», cioè nata dall’interpretazione della Scrittura (ermenéuein, in greco, significa «interpretare»)? La seconda domanda, esplicita, è: in che rapporto stanno tra loro i quattro sola tipici del protestantesimo: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus? La terza domanda, anch’essa esplicita, è: la rivelazione di Dio è chiusa o aperta? Il sola Scriptura ( = solo la Bibbia) non è forse un principio troppo esclusivo, cioè troppo limitato e limitante? 1. Alla prima domanda rispondo di sì: il protestantesimo è senza dubbio una «religione ermeneutica», fondata cioè sulla lettura intelligente della Sacra Scrittura: «intelligente» viene dal latino intellégere, che si può intendere come intus-légere, «leggere dentro», «capire in profondità». La Riforma è nata da una lettura in profondità della Sacra Scrittura. Lutero, com’è noto, ha scoperto l’Evangelo della grazia incondizionata meditando per anni sui Salmi (prima ancora che sulla lettera ai Romani e in particolare sui versetti-chiave 1, 16-17). Senza questo studio approfondito e appassionato della Bibbia non ci sarebbe stata la Riforma e quindi neppure il protestantesimo. E se mai dovesse accadere che il rapporto del protestantesimo con la Bibbia dovesse allentarsi, cessando di essere vincolante e determinante, il protestantesimo lentamente si estinguerebbe. Questo rischio c’è stato in passato, e c’è anche oggi. Il protestantesimo sta o cade con il suo rapporto con la Scrittura. Certo, la Riforma sa bene che è lo Spirito che vivifica, e non la Lettera, come dice l’apostolo Paolo in II Corinzi 3, 6. Ma «lo Spirito è nascosto nella lettera» (Spiritus latet in litera), dice Lutero. E proprio perché la lettera possiede ed esercita la forza dello Spirito, ecco come Lutero descrive la forza della Scrittura: «non è lei che si trasforma in colui che la studia, ma è lei che trasforma in se stessa e nella sua forza colui che l’ama… Infatti [mi dice la Scrittura] non sei tu che mi trasformi in te, ma sei tu a essere trasformato in me». Così grande è la forza realmente divina della Scrittura! Beato chi ne ha fatto o ne fa l’esperienza! D’altra parte però la Riforma in generale e Lutero in particolare non hanno identificato Bibbia e Parola di Dio, come se fossero la stessa cosa. Non lo sono. L’identificazione è avvenuta più tardi, con l’Ortodossia o Scolastica protestante. Ma nei Riformatori non c’è. Lo Spirito è nascosto nella lettera, ma non è la lettera. La divinità di Gesù è nascosta nella sua umanità, ma non è la sua umanità. La Bibbia contiene la Parola di Dio, ma non è la Parola di Dio. Questo perché «la Parola è diventata carne» (Giovanni 1, 14), non libro. «Dio e la Scrittura di Dio sono due cose [distinte], non meno che due cose [distinte] sono il Creatore e la creatura di Dio» (Lutero). In questo senso, classificare il cristianesimo e, al suo interno, il protestantesimo come «religione del Libro» è alquanto approssimativo e rischia di diventare fuorviante. Il Libro naturalmente c’è, ed è fondante e fondamentale. Ma Gesù Cristo non è un libro. Quindi il protestantesimo è, sì, «religione ermeneutica», cioè interpretativa di un testo, che è la Scrittura; questa però non è il traguardo ultimo della fede, bensì la via per raggiungerlo; non è il tesoro, ma il campo nel quale il tesoro è nascosto; non è la perla, ma la conchiglia che la racchiude. Il traguardo, il tesoro, la perla è Cristo. «Togli Cristo dalla Scrittura; che cosa ci puoi ancora trovare?». Il percorso della fede è dunque questo: a Cristo attraverso la Scrittura, nella forza dello Spirito. «Religione ermeneutica»? Sì, ma allora in un senso più profondo di quello indicato da Odifreddi: Cristo è il grande «ermeneuta», cioè l’interprete (l’evangelista Giovanni in 1, 18 dice «l’esegeta») di Dio e dell’uomo, e la Scrittura ci introduce nell’ermeneutica di Cristo. 2. Venendo alla seconda domanda, è anzitutto bene cercar di chiarire il senso e la portata dei famosi sola della Riforma, che possono facilmente dar luogo a malintesi. Sola Scriptura significa che solo la Scrittura, e non anche la Tradizione, è normativa per la fede e la vita cristiana. La tradizione ha il suo posto e il suo valore, ma non è normativa, è anch’essa sottoposta alla Scrittura. Sola fide significa che solo la fede salva, e non anche le opere, che sono ovviamente fondamentali, sono, per così dire, il corpo della fede, senza di loro la fede è come morta, esse però non salvano. Sola gratia significa che solo la grazia ci rende graditi a Dio, e non il merito. L’amore di Dio non ha bisogno di essere meritato, perché è donato, offerto gratuitamente a tutti senza condizioni. La risposta giusta alla grazia non è la ricerca del merito, ma la vita nella gratitudine (nulla è così raro sulla terra quanto la gratitudine). Solus Christus vuol dire che solo Cristo è mediatore, e non anche Maria e i Santi, solo lui intercede per noi presso il Padre, solo lui «ci è stato fatto da Dio sapienza, e giustizia, e santificazione, e redenzione» (I Corinzi 1, 30), solo in lui «sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza» (Colossesi 2, 3). Come si vede, i sola della Riforma non sono affatto solitari, non amputano in alcun modo la fede e la vita cristiana, anzi consentono di viverle pienamente, proprio perché servono a precisare la natura dell’Evangelo e a mettere bene in luce la sua verità. Quanto al rapporto tra i quattro sola, non è difficile indicarlo, e il nostro lettore sembra esserne già al corrente. Alla base di tutto c’è la Scrittura, vera «madre e maestra» (mater et magistra) della fede e della chiesa. È esplorando la Scrittura, e solo così, che si può scoprire che siamo giustificati per fede e non per opere, che siamo salvati per grazia e non per meriti, e che in Cristo soltanto abbiamo «tutto pienamente» (Colossesi 2, 9). Quindi il sola Scriptura è la fonte degli altri tre. 3. Ma questo sola Scriptura – si chiede il nostro lettore – non circoscrive forse in modo eccessivo l’azione di Dio? Non restringe troppo l’orizzonte? Non è forse un criterio troppo limitato e limitante? Dio si rivela solo nella Bibbia? Dobbiamo davvero pensare che quella biblica sia l’unica ed esclusiva rivelazione di Dio? La chiusura del canone biblico avvenuta alla fine del IV secolo (nel Sinodo di Ippona del 393) significa anche la chiusura della rivelazione divina? Questa rivelazione è chiusa o aperta? Grosse domande alle quali non è facile rispondere in poche battute. Comunque, ecco un abbozzo di risposta. Se il sola Scriptura viene inteso e vissuto in modo da non sfociare nel solus Christus, allora sì, è davvero limitante. Se invece sfocia nel solus Christus, allora no, non è limitante, perché in Cristo risiede la pienezza della rivelazione di Dio. Questa pienezza però è in parte ancora nascosta o inesplorata, deve ancora manifestarsi nella storia della chiesa, delle religioni, delle culture e dei popoli. La rivelazione di Dio è dunque chiusa nel senso che non c’è un altro Cristo diverso da Gesù di Nazareth che debba ancora venire: in lui la rivelazione è compiuta: è chiusa nel senso che è compiuta. Ma la rivelazione è aperta nel senso che la sua manifestazione è ancora incompiuta. Ci sono in Cristo dei «tesori» (Colossesi 2, 3) ancora da scoprire. E lo saranno, credo, mano a mano che l’umanità, in tutte le sue diversissime espressioni culturali e religiose, troverà in lui quel volto umano di Dio che la può salvare, liberandola da ogni forma di disumanità. La chiusura del canone biblico ha reso possibile alla fede cristiana di fare a meno di un nuovo pantheon e di confessare Cristo soltanto, nel quale Dio si è aperto a tutta l’umanità. Perciò la chiusura del canone biblico e la conseguente nascita della Scrittura cristiana non chiudono gli orizzonti, al contrario li rendono pressoché sconfinati. Chi si immerge nella Scrittura e vi scopre il tesoro nascosto, che è Cristo, vedrà la sua coscienza dilatarsi come mai prima, fino ad abbracciare non solo tutto ciò che è umano, ma anche tutto ciò che è creato, che in lui è stato «riconciliato» (Colossesi 1, 20) e sotto di lui dev’essere «ricapitolato» (Efesini 1, 10). Un’apertura più grande di questa non c’è. Tratto dalla rubrica "Dialoghi con Paolo Ricca" del settimanale Riforma del 2 novembre 2007 Paolo
Ricca pastore e professore emerito della Facoltà Valdese di
Teologia di Roma
|